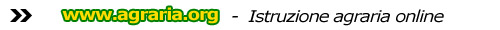Pustertaler
Atlante delle razze bovine - Razze minori italiane
Origine e zona di diffusione
Originaria della Val Pusteria in provincia di Bolzano. Deriva dall'incrocio di Pinzgau con razze pezzate nere e pezzate rosse. Dal secondo dopoguerra è stata massicciamente sostituita da Pinzgau. Presenti pochi capi in Val Pusteria.
Dal 1985 è stato istituito il Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione. Tale registro è stato istituito per salvaguardare le razze bovine minacciate di estinzione che risultano allevate in Italia e per la salvaguardia di questi patrimoni genetici. Sono state ammesse le seguenti razze: Agerolese, Bianca Val Padana (Modenese), Burlina, Cabannina, Calvana, Cinisara, Garfagnina, Modicana, Mucca Pisana, Pezzata Rossa d'Oropa, Pinzgau, Pontremolese, Pustertaler, Reggiana, Sarda, Sardo-Modicana, Varzese.
Caratteristiche morfologiche
Mantello pezzato rosso (mogano) o nero, con rosso o nero che predomina decisamente.
Presenta una tipica fascia bianca che circonda il corpo longitudinalmente.
Animali armonici, con taglia e statura media.
Caratteristiche produttive
Razza a duplice attitudine con lieve prevalenza per il latte.
Molto idonea all'ambiente alpino, anche se ormai si è perso quasi completamente il patrimonio genetico (pochissimi esemplari, razza reliquia).
 Bovine di razza Pustertaler
Bovine di razza Pustertaler
 Toro di razza Pustertaler
Toro di razza Pustertaler
La razza bovina Barà allevata in Piemonte riconducibile alla Pustertaler
di Battaglini L., Ighina A., Mimosi A., Bianchi M.
Lo studio scaturisce dall’interesse un gruppo di allevatori della Val Sangone (in provincia di Torino) che, nel 2001, si rivolse al Dipartimento di Scienze Zootecniche e alla Regione Piemonte segnalando la presenza in allevamento di un tipo di bovino che fino ad allora non era stato sottoposto ad alcuna forma di controllo ufficiale. Questa popolazione, localmente denominata Barà, viene allevata da lungo tempo per la sua equilibrata duplice attitudine alla produzione di latte e carne e per la buona adattabilità ad ambienti difficili come quelli montani. Queste favorevoli caratteristiche hanno determinato il mantenimento di questi soggetti all’interno di numerosi allevamenti nelle vallate della provincia di Torino. Nonostante la mancanza di un registro anagrafico, e di qualsiasi forma di controllo o selezione ufficiale, si è in ogni modo mantenuta una razza-popolazione alpina con una discreta consistenza numerica (intorno a 4.000 capi).
Caratteristiche della razza
Il carattere distintivo è rappresentato dal mantello che presenta spruzzatura irregolare, con aree pigmentate (di colore nero o rosso-castano) di estensione variabile, ma, in tutti i soggetti, presenti maggiormente sui fianchi, sul musello, le orecchie e le parti distali degli arti. Per quanto riguarda l’origine della popolazione Barà attualmente rinvenibile in in Piemonte sono state formulate diverse ipotesi: la prima farebbe risalire la provenienza di questi capi in ad epoche remote, a seguito delle migrazioni delle popolazioni Walser. Un’altra è legata alla testimonianza di alcuni allevatori che ricondurrebbero la presenza di questi soggetti ai primi del ‘900, quale conseguenza dei numerosi flussi di immigrazione coinvolgenti anche gruppi di allevatori, avvenuti negli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale. Altre testimonianze riconducono la presenza sul territorio di questa razza alla notevole movimentazione di animali, avvenuta tra gli anni ‘60 e ‘70, ad opera di alcuni commercianti di bestiame della provincia di Torino. Lo scopo di questo lavoro è stato chiarire l’origine di tale razza-popolazione attraverso il confronto di genotipi di razze dell’arco alpino che manifestano una evidente affinità fenotipica (Pustertaler e Vosgienne) e approfondire le conoscenze relative alle caratteristiche morfologiche e produttive, in modo da arrivare ad una precisa caratterizzazione di questo tipo di bovini. La prima parte dell’indagine ha riguardato il prelievo di campioni di materiale biologico (bulbi piliferi) da soggetti bovini Barà da inviare al Laboratorio dei Gruppi Sanguigni (LGS) di Cremona che ha provveduto a costruire una mappatura genetica ed ha operato un confronto tra le distanze alleliche di alcune razze rappresentative. Per questa analisi sono stati usati 59 campioni Barà, 27 Pustertaler, 50 Frisona e 50 Piemontese. Sono state calcolate le distanze genetiche tra questi 4 gruppi con il programma MICROSAT in base alla proporzione di alleli condivisi. La matrice delle distanze è stata usata per costruire il diagramma N-J con il metodo Neighbour-Joining. I soggetti interessati al campionamento sono stati scelti mantenendo come vincolo quello della non parentela tra essi per almeno due generazioni e di avere un aspetto esteriore comune a quelli che usualmente sono definiti bovini di tipo Barà. Su un totale di 56 allevamenti visitati nelle valli Sangone, Susa, Lanzo, Pellice, nel Canavese e nella pianura torinese, sono stati prelevati complessivamente 59 campioni. L’indagine sulle caratteristiche morfologiche e produttive ha, invece, interessato 14 aziende nelle vallate alpine della provincia di Torino: 2 nelle Valli di Lanzo, 4 in Val di Susa, 5 in Val Sangone e 3 nelle valli Pellice e Chisone. Le aziende scelte hanno indirizzi produttivi volti sia alla produzione di latte, trasformato in prodotti caseari sia di carne, grazie alla equilibrata duplice attitudine caratterizzante i bovini Barà; tutte praticano l’alpeggio nel periodo estivo. In ciascun allevamento sono stati individuati 10 soggetti considerati rappresentativi della razza-popolazione Barà. Su queste bovine sono stati compiuti prelievi del latte rilevandone anche la quantità prodotta. Sui campioni raccolti sono state effettuate analisi riguardanti le caratteristiche merceologiche (grasso, proteine, lattosio), la determinazione del tenore di urea ed il conteggio delle cellule somatiche. I prelievi sono stati effettuati a cadenza stagionale in periodi considerati rappresentativi sia del sistema di allevamento che del tipo di alimentazione. Analogamente a molte aziende con bovini dell’areale alpino piemontese tutti gli allevamenti considerati presentano un sistema zootecnico che si basa sull’utilizzo di pascoli aziendali nel periodo primaverile e autunnale; durante l’estate gli animali vengono portati negli alpeggi alle quote più alte mentre nella stagione invernale vengono tenuti a stabulazione fissa con un’alimentazione basata quasi esclusivamente su fieno e insilati. Per quanto riguarda i parametri morfologici, sui soggetti controllati sono stati misurati: altezza al garrese, circonferenza toracica, lunghezza del tronco e peso.
Risultati
Dai primi risultati ottenuti, confrontando il genotipo dei campioni inviati e i dati disponibili per le altre razze, è emerso come non vi sia alcuna significativa separazione tra i gruppi della popolazione Barà e della Pustertaler, razza allevata in Austria e in Alto Adige, dove ne rimangono alcune centinaia di capi. Circa il confronto con le altre due razze è apparso chiaramente come Barà e Pustertaler abbiano una origine comune e non possano essere considerate come appartenenti a due gruppi chiusi e separati. Per entrambe si può osservare una evidente distanza genetica rispetto alla Frisona, mentre, soltanto per la Barà, appare evidente la vicinanza con la Piemontese, risultato che può essere facilmente spiegabile dato il frequente impiego per la monta anche di tori di tale razza.
I rilievi sulle caratteristiche morfologiche hanno portato a rilevare una certa variabilità sia tra allevamenti che tra i soggetti di una stessa azienda: questo perché, fino ad oggi ogni allevatore ha puntato sulle caratteristiche che più riteneva utili, non essendo prevista alcuna forma di selezione concordata. L’altezza al garrese è risultata in media di 135 cm, la circonferenza toracica di 198 cm e la lunghezza del tronco di 163 cm, per un peso medio di 660 kg.
Analoga variabilità si è potuta riscontrare nei risultati riguardanti le analisi del latte, sia per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche che per gli altri parametri qualitativi. E’ emersa peraltro una produttività del tutto soddisfacente se abbinata alle interessanti caratteristiche qualitative.
Caratteristiche quanti-qualitative latti individuali (medie ± DS) (n=140)
| inverno | primavera | estate | autunno | |
| Latte prodotto (kg) | 10,6 ± 3,5 | 12,2 ± 3,5 | 8,8 ± 3,8 | 10,3 ± 4,3 |
| Grasso (%) | 3,8 ± 0,6 | 3,6 ± 0,5 | 3,9 ± 0,8 | 3,7 ± 0,6 |
| Proteine (%) | 3,5 ± 0,5 | 3,2 ± 0,2 | 3,3 ± 0,3 | 3,5 ± 0,4 |
| Lattosio (%) | 4,8 ± 0,3 | 4,9 ± 0,2 | 4,7 ± 0,2 | 4,8 ± 0,3 |
| CCS (n*1000/ml) | 333 ± 308 | 208 ± 209 | 324 ± 273 | 243 ± 246 |
| Urea (mg/100 ml) | 22,5 ± 5,6 | 23,4 ± 3,5 | 22,3 ± 4,6 | 24,8 ± 5,4 |
Conclusioni
Gli studi effettuati dimostrano come ci si trovi di fronte ad una scoperta piuttosto interessante per la zootecnica montana piemontese e non solo. Tale razza, La razza Barà, oltre che rappresentare un importante serbatoio genetico per i bovini di razza Pustertaler, che in Alto Adige sono ormai ridotti a qualche centinaio di capi, si è dimostrata di particolare convenienza per le sue attitudini produttive e per la grande rusticità e adattabilità ad ambienti particolarmente difficili quali sono molti alpeggi piemontesi. In un territorio dove vengono prevalentemente allevate le bovine di razza Piemontese e Valdostana Pezzata Rossa, (due razze ormai specializzate nelle produzioni rispettivamente di carne e di latte), valorizzare un bovino a duplice attitudine, quale ha dimostrato essere la Barà, potrebbe rappresentare la chiave per un recupero di redditività in aree marginali montane e per una ulteriore tutela e valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie che si realizzano in questi ambienti.