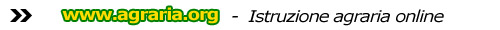Ficodindia dell'Etna DOP
Atlante dei prodotti tipici - Ortofrutticoli DOP e IGP
Zona di produzione
La zona di produzione del“Ficodindia dell'Etna DOP” comprende i territori della provincia di Catania, ubicati ad una altitudine che va dai 150 ai 750 m s.l.m., e ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Camporotondo, Belpasso e Paterno'.
Consumo
Il “Ficodindia dell'Etna DOP” viene consumato preferibilmente fresco, come frutto da tavola: deve essere servito freddo e ben sbucciato, per evitare le spine. Viene però anche utilizzato per preparare macedonie, confetture e liquori.
 Ficodindia dell'Etna DOP (foto www.tetysite.it)
Ficodindia dell'Etna DOP (foto www.tetysite.it)
Disciplinare di produzione - Ficodindia dell'Etna DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione d’origine protetta «Ficodindia dell’Etna» è
riservata ai frutti del ficodindia che devono rispondere alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) 2081/92 ed indicati nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Piattaforma varietale
Le cultivar della «Opuntia ficus-indica» dell’area
considerata sono: gialla detta anche «Sulfarina» o «Nostrale», rossa detta anche«Sanguigna», bianca detta anche «Muscaredda» o «Sciannarina». È ammessa una
percentuale non superiore al 5% di altri ecotipi. Sono considerati varianti di pregio
le selezioni «Trunzara» o «Pannittera», delle cultivar bianca, rossa e gialla.
Articolo 3.
Zona di produzione
La zona di produzione del «Ficodindia dell’Etna», che va dai
150 ai 750 m s.l.m., ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano,
Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Camporotondo, Belpasso e Paternò.
In particolare i confini sono così individuati:
Bronte: ad ovest lungo il fiume Simeto, a nord con la strada Bronte-Cesarò, ad
est con la quota 750 m s.l.m., a sud con il territorio del comune di Adrano;
Adrano: ad ovest lungo il fiume Simeto, a nord con il territorio del comune di
Bronte, ad est con la quota 750 m s.l.m. ed il territorio del comune di
Biancavilla, a sud con il territorio del comune di Biancavilla;
Biancavilla: ad ovest lungo il fiume Simeto ed il territorio del comune di
Adrano, a nord con il territorio del comune di Adrano e la quota 750 m s.l.m.,
ad est con il comune di S. Maria di Licodia, a sud lungo il fiume Simeto;
Santa Maria di Licodia: ad ovest con il comune di Biancavilla, a nord con la
quota 750 m s.l.m. e il territorio del comune di Ragalna, a est con il comune di
Ragalna, a sud con la strada ss 575 (Schettino) ed il territorio del comune di
Paternò;
Ragalna: ad ovest con il territorio di S. Maria di Licodia, a nord con la strada
Nicolosi-Ragalna, ad est con il territorio del comune di Belpasso, a sud con il
territorio del comune di Paternò;
Paternò: ad ovest lungo la sp 137 fino al Simeto e lungo la strada Rocca di
Pietralunga e di Contrada Buffa sino alla ss 575, a nord con il territorio dei
comuni di S. Maria di Licodia e Ragalna, ad est con il territorio del comune di
Belpasso, a sud con la strada ferrata Circumetnea;
Belpasso: ad ovest con i comuni di Ragalna e Paternò, a nord con la strada
Nicolosi-Ragalna, ad est con la strada Belpasso-Etna e Belpasso-Camporotondo sino al confine del territorio comunale, a sud con il confine del
territorio comunale lungo la strada Camporotondo-Valcorrente ss 121.
Camporotondo Etneo: ad ovest con il territorio del comune di Belpasso e la
lava del 1669, a nord con il centro abitato, ad est con la strada Camporotondo-Misterbianco fino al bivio per Piano Tavola e alla ss 121.
Articolo 4.
Origine del prodotto, cenni storici, importanza e diffusione.
Lo storico Denis
Mack Smith in History of Sicily - Medieval Sicily 800-1713: «alla fine del
sedicesimo secolo in Sicilia, gli spagnoli introdussero alcune nuove e importanti
piante come il pomodoro dal Perù, mais e tabacco dal Messico. Quello più
comunemente usato era il ficodindia proveniente dall’America Tropicale (Indie
occidentali, secondo C. Colombo). I fichidindia (Indian fig. - prickly pear cactus)
trasformeranno le campagne della Sicilia, capaci di sopportare lunghe siccità e di
propagarsi facilmente nelle spaccature delle rocce, infatti venivano di proposito
piantati per frantumare la lava nei fertili pendii del monte Etna. Questa
ammirevole pianta a siepi con i suoi frutti ha contribuito alla dieta di ricchi e di
poveri nella vita quotidiana dei siciliani».
W.H. Barlett nelle Pictures from Sicily (1853): «ma di tutte le produzioni di
vegetali della parte bassa dell’Etna il ficodindia, è forse quella che meglio si
sviluppa e si riproduce con sorprendente rapidità».
Riferimenti sul ficodindia (fichi opunzia) nella «zona coltivata dell’Etna», così
definita ai tempi di Spallanzani (1792), si trovano anche nelle opere di P.
Bembo, Borelli, Stoppani, Brydone, ecc.
Coppoler S., «Del ficodindia, sua coltivazione in Sicilia e modo di ottenere i
frutti tardivi (“scuzzulari”)». Saggio storico-agrario (1827).
Il Mortillaro riporta su «Notizie economico-statistiche», ricavate dai catasti di
Sicilia (1853), le superfici destinate a «Ficheti d’India».
«Atti della Giunta per l’inchiesta agraria» - Jacini (1884):
vengono riportate le superfici destinate a «Ficheti d’India» in Sicilia.
Legame con l’ambiente geografico: nel versante sud-occidentale, delle pendici
dell’Etna, il ficodindia ha trovato le condizioni ideali per divenire un elemento
caratterizzante del paesaggio.
Le condizioni ambientali per la coltura devono essere quelle tradizionali e
caratteristiche della zona etnea.
La zona di produzione, risulta caratterizzata da un clima mediterraneo
subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata
nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e
la notte.
I terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l’umidità ed in particolare la
lunga esposizione ai raggi solari, conferiscono al frutto caratteristiche di qualità
(colore, serbevolezza e consistenza) difficilmente riscontrabili in altre aree di
produzione e nello stesso massiccio etneo.
Articolo 5.
Terreni - impianti - tecniche colturali - raccolta - lavorazione
Terreni: i terreni,
di origine vulcanica o no, destinati alla coltura, dovranno essere ubicati nella zona
di produzione di cui al precedente art. 3 e possedere i seguenti requisiti:
tessitura media o grossolana per evitare ristagni d’acqua (è ammessa la
presenza di roccia affiorante).
Preparazione dei terreni: nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono
essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il drenaggio delle
acque, le operazioni colturali e le concimazioni.
Impianti: gli impianti possono essere sia specializzati che consociati e la densità di
piantagione massima ammessa, in dipendenza della tipologia di impianto, è di 400
piante ad ettaro.
In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante («vaso libero» o «a
cespuglio»), è ammesso altro tipo di allevamento, per agevolare la raccolta e le
operazioni colturali.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere
quelli tradizionali. Sono consentite negli impianti, a sostegno del nuovo flusso
vegeto-produttivo, le operazioni di concimazione, di irrigazione dopo la«scozzolatura» (che consiste nell’asportare fiori, frutticini appena allegati e
giovani cladodi).
Tecniche colturali: le tecniche colturali del terreno non devono danneggiare
l’apparato radicale delle piante che si espande in superficie.
La scozzolatura viene eseguita tra la fine del mese di maggio e la prima metà del
mese di giugno, in relazione alle zone di produzione e alle condizioni climatiche.
Raccolta: le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e
all’andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto per i frutti di
prima fioritura («Agostani»), da settembre a dicembre per i frutti di seconda
fioritura («Scozzolati» o «Bastardoni»). I frutti dopo la raccolta devono essere
immagazzinati in locali idonei ventilati e asciutti.
Successivamente il prodotto può essere frigoconservato.
Le operazioni di raccolta vanno iniziate all’invaiatura eseguendo il prelievo in
modo tale che una sottile porzione di cladodio rimanga alla base del frutto.
Successivamente alla raccolta i frutti debbono essere sottoposti al processo di
despinatura, per essere commercializzati con la qualifica di despinati.
Immagazzinamento e lavorazione: le operazioni di immagazzinamento e prima
lavorazione, per l’acquisizione delle caratteristiche organolettiche previste per
l’immissione al consumo di cui al successivo art. 5, devono essere effettuate
esclusivamente nel territorio ricadente nell’area delimitata con il presente
disciplinare. Le tecnologie di gestione post-raccolta prevedono l’omogeneità del
prodotto e la despinatura.
6. Caratteristiche del prodotto. I frutti vengono distinti in ordine al periodo di
maturazione:
«Agostani» o «Latini» (primo fiore);
«Scozzolati» (seconda fioritura).
Cultivar: gialla, rossa, bianca.
I «Fichidindia dell’Etna» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere
alle comuni norme di qualità e alle seguenti caratteristiche:
- peso frutto non inferiore a 95 g;
- percentuale di polpa non inferiore al 60% del peso fresco dell’intero frutto;
- frutti esenti da malformazioni;
- colore e forma, caratteristici della cultivar (sono ammessi frutti raccolti nella
fase di invaiatura);
- grado rifrattometrico non inferiore al 13%;
- rintracciabilità: per consentire l’attività di controllo e vigilanza agli organismi
certificatori, il prodotto D.O.P. sarà quello dei produttori operanti nel territorio
di cui all’art. 3 e che dovranno risultare iscritti in un apposito elenco.
Articolo 7.
Controlli e vigilanza
I controlli e la vigilanza saranno garantiti da organismi
rispondenti all’art. 10 regolamento (CEE) 2081/92.
Articolo 8.
Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto, lavorato e despinato, va immesso al
consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia, conformi alla normativa
vigente, in legno, cartone e plastica. È ammesso, secondo le tradizioni la presenza,
nello stesso contenitore, delle tre diverse cultivar.
Il «Ficodindia dell’Etna» può essere immesso al consumo solo con il logo della
denominazione d’origine protetta figurante su ogni confezione commerciale, nel
rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso.
Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente
distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Ficodindia dell’Etna». È
consentita l’utilizzo della dicitura «Cactus Pear».
Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale,
indirizzo del confezionatore, peso lordo all’origine, nonché l’eventuale nome delle
aziende da cui provengono i frutti. È facoltativa l’indicazione della settimana di
raccolta del prodotto ed i termini «Agostani» o «Latini» e «Scozzolati» o«Bastardoni» riferiti all’epoca di maturazione.
Il marchio d’identificazione è rappresentato dalla scritta D.O.P. Denominazione
d’origine protetta, dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, da due
cladodi con quattro frutti e sottostante scritta «Ficodindia dell’Etna», con a destra
il logo D.O.P. CEE.